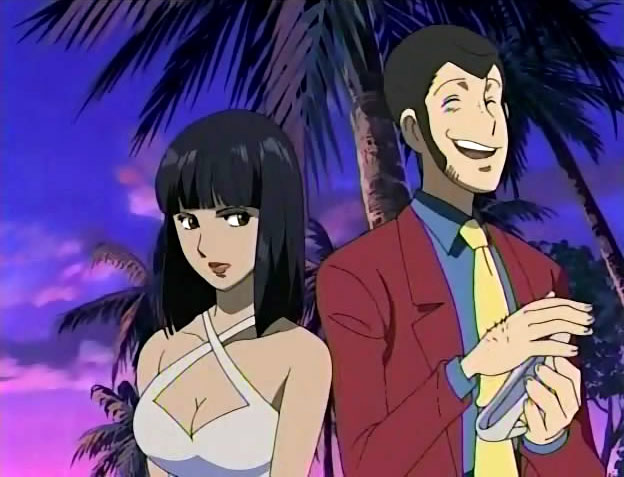Parlando di Radio Capodistria e della RAI del Friuli ho avuto modo di accennarvi come spesso la mia attenzione vada al Friuli e a quella zona dove, con poco più di un'ora di macchina, sei in Slovenia o in Austria.
Parlando di Radio Capodistria e della RAI del Friuli ho avuto modo di accennarvi come spesso la mia attenzione vada al Friuli e a quella zona dove, con poco più di un'ora di macchina, sei in Slovenia o in Austria.Vi confesso che a prima vista non era stato amore. La colpa non era tanto di Tomizza o del libro, quanto del fatto che avevo preso il libro per caso. Soffrivo da un paio di settimane di un fastidioso mal di denti (e annesso mal d'orecchi) e, infastidito da giorni di sopportazione - è il caso di dirlo! - a denti stretti, sono andato dal dentista. Che ovviamente ha deciso di passare col trapano senza anestesia.
Dolore, fischi all'orecchio, giramento di palle e di testa. Sempre il caso voleva che vicino allo studio del dentista si trovasse una grande libreria: niente di meglio per distrarsi dal fastidio di immergermi tra i libri, si sa mai che capitasse qualche libro gustoso.
E' così che ho deciso di prendere una copia di Materada, attratto da un nome, quello di Tomizza, che avevo sentito molte volte nelle mie peregrinazioni nel mare delle onde medie. Senonché ho cominciato a leggere proprio per distrarmi dal fastidio. Era inevitabile che la lettura e il dolore si sovrapponessero, non facendomi godere le prime venti/trenta pagine e facendomi credere di trovarmi davanti ad un libro che non valeva la pena. Madonna, che maledettamente diretto che è sto libro, ho pensato, mentre il libro finiva sullo scaffale.
Qualche settimana dopo, lasciati alle spalle stress e mal di denti e con la voglia di uscire dal recinto germanistico, tiro fuori Materada e riprendo la lettura da dove avevo interrotto. Effettivamente la prosa di Tomizza è nuda, priva di qualsiasi genere di retorica, cruda, però si adatta bene al contenuto del romanzo.
Siamo nel 1954 e siamo in pieno dopoguerra; l'Italia è ancora incerta sui suoi confini, quando arriva il Memorandum di Londra: Istria divisa in due zone, la A, quella con Trieste e destinata all'Italia, e la B, destinata alla Jugoslavia. Gli abitanti si domandano se convenga rimanere in Jugoslavia o passare all'Italia. Questo pressante interrogativo non risparmia il piccolo paese di Materada e il protagonista del romanzo, Francesco Coslovic, diviso tra l'amore per la propria terra e la prospettiva di rimanervi rischiando la miseria per la mancanza di una piccola proprietà terriera da lavorare.
Non anticipo oltre, non sarebbe giusto. Questo accenno al "plot" del libro serve però a capire che la prosa nuda di cui parlavo qualche riga fa ben si adatta a questo scenario misero e desolante. Tomizza non fa sconti: il ricordo del proprio vissuto da parte del protagonista non diventa occasione di mitizzazione del passato o di lirica nostalgia, ma al contrario è fredda rievocazione/registrazione di un periodo che può essere tutto tranne che vagheggiato.
Materada è un libro forte, estremamente amaro, ma proprio qui sta la sua bellezza. Angosciante nella sua trasparenza, Materada è una lezione di antropologia, in cui siamo messi prepotentemente davanti all'intrinseca ferocia e all'opportunismo dell'uomo, e di storia, una storia recente verso la quale la nostra generazione pare non aver alcun interesse. Ed è un peccato, perché scopriremmo con stupore che l'Italia come la conosciamo è, in fin dei conti, un paese tutt'altro che vecchio.
Materada è un libro forte, estremamente amaro, ma proprio qui sta la sua bellezza. Angosciante nella sua trasparenza, Materada è una lezione di antropologia, in cui siamo messi prepotentemente davanti all'intrinseca ferocia e all'opportunismo dell'uomo, e di storia, una storia recente verso la quale la nostra generazione pare non aver alcun interesse. Ed è un peccato, perché scopriremmo con stupore che l'Italia come la conosciamo è, in fin dei conti, un paese tutt'altro che vecchio.